Italia-Giappone: 150 anni di amicizia costante
Noemi Lanna (Professore associato di Storia e istituzioni del Giappone,
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”)
Il 25 agosto 1866 Italia e Giappone firmavano il Trattato di amicizia e di commercio che auspicava “pace perpetua ed amicizia costante tra Sua maestà il Re d’Italia e Sua maestà il Taicoun, i loro eredi e successori” e tra i rispettivi popoli, “senza eccezione di luogo o persona”. L’augurio, formulato nel primo articolo dell’accordo, è diventato realtà: nei 150 anni trascorsi dalla firma del trattato, le relazioni tra Italia e Giappone sono state costantemente amichevoli.
Nel periodo successivo all’apertura delle relazioni ufficiali, varie circostanze contribuirono a determinare una significativa convergenza di interessi tra i due paesi. Innanzitutto, Italia e Giappone erano uniti da complementari esigenze commerciali. L’Italia, per la quale la sericoltura costituiva una fondamentale attività economica, era alle prese dal 1854 con una perniciosa infezione che aveva colpito quasi tutte le aree sericole della penisola. Questa epidemia, diffusa anche nel resto d’Europa, spinse gli imprenditori italiani a guardare con interesse al mercato delle uova di baco da seta giapponese. Per il Giappone, d’altro canto, la domanda italiana costituiva un’importante fonte di rendita: si calcola che tra la fine del periodo Tokugawa (1603-1868) e l’inizio del periodo Meiji (1868-1912) l’Italia sia arrivata ad assorbire fino ad un quinto delle esportazioni giapponesi. Oltre che da fattori commerciali, la cordiale intesa tra i due popoli era favorita anche dall’aura di simpatia creata intorno all’Italia dal Risorgimento. Agli occhi dei giapponesi, l’esperienza risorgimentale italiana appariva molto simile alle vicende che, pressappoco negli stessi anni, avevano causato la fine dello shogunato e la Restaurazione Meiji (1868).
Con queste premesse, non stupisce che, nel 1881, il vascello italiano Vettor Pisani sia stata la prima imbarcazione straniera a ricevere l’onore di una visita dell’Imperatore giapponese. Del resto, l’ottimo stato delle relazioni bilaterali era stato confermato anche otto anni prima, in occasione della visita in Italia della missione Iwakura (1871-3). La missione diplomatica, salpata dal Giappone alla volta degli Stati Uniti e dell’Europa, aveva il duplice scopo di presentare le credenziali del nuovo governo giapponese agli stati visitati e di far acquisire al Giappone conoscenze dirette sulle loro istituzioni politiche, economiche e giuridiche. In Italia, la delegazione giapponese si fermò dal 9 maggio al 3 giugno 1873, visitando varie città. Nel 1888, fu istituita la Società italo-giapponese (Nichi-I gakkai) che grande impulso avrebbe dato alla reciproca conoscenza della cultura dei due paesi.
La Prima guerra mondiale vide Italia e Giappone schierati al fianco delle potenze della Triplice intesa (Francia, Gran Bretagna, Russia). Anche dopo la firma del trattato di pace, le strade dei due paesi non si separarono. Nel clima fortemente impregnato di idealismo dell’immediato dopoguerra, Roma e Tokyo diventarono sempre più vicine: sul piano simbolico, in seguito alla visita in Italia del futuro imperatore Hirohito, avvenuta nel 1920; sul piano materiale, grazie al primo volo Roma-Tōkyō, effettuato nello stesso anno da due piloti italiani. Purtroppo, i due paesi finirono col condividere anche il nefasto processo che portò alla crisi della democrazia liberale e all’espansionismo militaristico, come testimoniato dal Patto anti-Komintern (1937) e dal Patto tripartito (1940).
Il 1945 segnò un nuovo inizio per Giappone ed Italia. Ancora una volta, le scelte dei due paesi si incrociarono. La neo-nata Repubblica italiana fondò la sua esistenza sui valori democratici dell’antifascismo, della Resistenza e del ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Il Giappone fece della democrazia e del pacifismo le basi della sua rinascita. Complessivamente, gli anni della Guerra fredda sono stati un periodo molto proficuo per i due paesi: il dialogo politico si è sviluppato ai più alti livelli e il volume degli scambi commerciali è progressivamente aumentato. Le iniziative in ambito culturale si sono intensificate, grazie alla preziosa attività dell’Istituto giapponese di cultura (inaugurato a Roma nel 1962) e del ricostituito Istituto italiano di cultura (riaperto a Tokyo nel 1959). Inoltre, l’erogazione di numerose borse di studio ha consentito a generazioni di giovani studiosi dei due paesi di venire in contatto, creando una vera e propria comunità accademica transcontinentale.
Vari fattori hanno contribuito a perpetuare l’amicizia e la pace tra i due paesi. In primo luogo, va ricordato che la firma del Trattato di amicizia e commercio (1866) non fu preceduta soltanto dalle già menzionate missioni commerciali dei setaioli italiani, ma anche da reiterati e significativi contatti tra i due paesi, le cui origini risalgono al sedicesimo secolo. Proprio quest’anno, si è celebrato il quattrocentesimo anniversario dell’arrivo a Roma della missione guidata dal giapponese Hasekura Tsunenaga, partita da Sendai nel 1613. Come è stato meticolosamente documentato dai contributi contenuti nei volumi Italia-Giappone 450 anni (curati dal Professor Adolfo Tamburello) ai quali si rinvia per approfondimenti, quella tra Italia e Giappone è una relazione di lunga durata, che ha toccato vari aspetti della vita politica, economica e culturale dei due paesi.
In secondo luogo, il contesto internazionale all’interno del quale si sono sviluppati i rapporti tra Giappone ed Italia ha inciso positivamente sulla relazione bilaterale. Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, quando fu concluso il Trattato di amicizia e commercio, Italia e Giappone erano due late-comer, cioè due paesi che avevano intrapreso i loro rispettivi processi di modernizzazione in ritardo rispetto alle grandi potenze che all’epoca dominavano il sistema internazionale. Per questo motivo, Roma e Tokyo dovettero misurarsi con gli stessi vincoli sistemici e perseguirono gli stessi obiettivi, cioè la ricerca del prestigio e del riconoscimento all’interno dell’arena internazionale. Allo stesso modo, dopo il 1945, quando il sistema internazionale assunse una struttura bipolare, Giappone e Italia si trovarono nuovamente a dover rispondere a sfide analoghe. Nel mondo rigidamente diviso in blocchi, la priorità divenne garantire la sicurezza del proprio territorio, senza pregiudicare la possibilità di una rapida ripresa del sistema economico, fortemente danneggiato dalla guerra. Anche in questo caso, i due paesi operarono scelte simili: optando per un allineamento (bandwagoning) con gli Stati Uniti, riuscirono a massimizzare i vantaggi della loro peculiare collocazione geografica e ad assicurare pace e prosperità alle loro popolazioni. Ancora oggi, Giappone e Italia continuano a camminare fianco a fianco, forti dei profondi legami che le uniscono.
N.B. Il contenuto del presente testo non rispecchia le opinioni del governo.
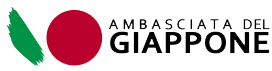
 日本語/GIAPPONESE
日本語/GIAPPONESE